Panel 1
Marina Colaiezzi
The indicator evaluates the demand for freight transport (also in relation to economic growth) and the evolution over time of modal split. The transport demand is increasingly met by road freight transport, which continues to dominate other transport modes in terms of growth and modal share (approximately 62% in 2023).
The indicator measures freight transport demand, broken down by different transport modes and their respective intensities.
To assess freight transport demand and compare its trend with economic growth, as well as to evaluate the evolution of modal split over time, aiming for a more balanced distribution.
The need for a sustainable transport system has been repeatedly emphasized at the EU level, particularly in the fight against climate change (European Parliament, 2008; European Council, 2008). Key objectives for sustainable mobility include decoupling transport growth from economic growth and rebalancing modal shares. In May 2018, with the third set of measures under "Europe on the Move," an initiative for clean, competitive, and interconnected mobility, the European Commission completed the process initiated with the 2016 "European Strategy for Low-Emission Mobility" and the previous packages of May and November 2017. In Italy, the Guidelines of the General Mobility Plan (MT, 2007) identified modal integration as essential for an efficient transport system.
In December 2019, the "National Integrated Energy and Climate Plan" was submitted to the European Commission, followed in January 2021 by the draft "Italian Long-Term Strategy for Greenhouse Gas Emission Reduction," which outlines measures to shift freight transport from road to rail and from road to sea. Additionally, concerning intermodal exchange, regulatory instruments such as Marebonus and Ferrobonus are key measures for energy efficiency in transport, as modal shift represents a highly cost-effective intervention. Specifically, Marebonus provides incentives to road freight companies for adopting combined road-sea transport, while Ferrobonus offers incentives for combined road-rail transport.
At the end of 2019, the European Commission adopted the European Green Deal, COM(2019) 640 final, a program to achieve net-zero greenhouse gas emissions by 2050. To contribute to carbon neutrality, the Green Deal proposes shifting 75% of inland freight transport from road to rail and inland waterways. These goals were reinforced by Italy’s National Recovery and Resilience Plan (PNRR, January 2021), which highlights that the lack of efficient infrastructure also affects freight transport: without effective rail connections, road transport remains the primary option. In February 2023, the legislative decree for PNRR implementation was issued, and in June 2024, Italy communicated the update of its National Energy and Climate Plan (PNIEC) as required by Article 14 of Regulation (EU) 2018/1999.
To increase rail freight volumes, it is necessary to expand network and node capacity while improving connections between rail networks, ports, and airports. In this context, the EU’s "Strategy for Sustainable and Smart Mobility" sets the goal of increasing rail freight traffic by 50% by 2030 and doubling it by 2050.
[1] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/24/23G00022/sg.
Panel 2
National Infrastructure and Transport Report – Years 2022-2023’ (CNIT 2022-2023)*- MIT – Ministry of Infrastructure and Transport (Italy)
*CNIT (Conto Nazionale Infrastrutture e Trasporti): Italy’s official transport accounting system.
Lack of data comparability across transport modes
-
Data quality assessment
-
EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities)
-
ISPRA (Italian National Institute for Environmental Protection and Research)
-
ISTAT (Italian National Institute of Statistics)
-
MIT (Ministry of Infrastructure and Transport – Italy)
The information on total freight traffic is compiled by ISPRA using data series derived from surveys conducted by ISTAT (http://demo.istat.it/), Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/data/database), National Infrastructure and Transport Report – Years 2022-2023 (CNIT 2022-2023)* (https://www.mit.gov.it/comunicazione/pubblicazioni), and the AMECO macro-economic database (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_en).
*CNIT (Conto Nazionale Infrastrutture e Trasporti): Italy’s official transport accounting system.
Nazionale
1990-2023
Indicator assessment
The indicators are derived through simple mathematical processing based on tonne-kilometre data from the 2022–2023 National Transport and Infrastructure Report (CNIT 2022-2023) and on estimates of total vehicle mileage, provided by the national atmospheric emissions inventory section of ISPRA. These estimates are produced using the European COPERT model. The methodology takes into account overall fuel consumption, actual traffic data from the toll motorway network, and periodic studies conducted by trade associations. Circulation data are further processed by incorporating ISTAT population estimates and European Commission estimates (sources: Eurostat and AMECO) for Gross Domestic Product (GDP).
Estimates of domestic freight traffic for 2023 amount to approximately 199 billion tonne-kilometres, marking a decrease of around 1.6% compared to 2022. The data series confirms the overwhelming dominance of road transport, which in 2023 accounted for 62.4% of total freight tonne-kilometres (Table 1). Road transport exerts significant pressure on road infrastructure and society as a whole, generating congestion, delays, and other negative externalities. Furthermore, the expansion of its modal share has offset progress made in reducing environmental impacts and improving transport safety—achievements largely due to technological advancements and infrastructure interventions.
With regard to other transport modes, the following year-on-year changes were recorded in 2023: -4.7% for waterborne transport (maritime and inland navigation); -6.1% for fixed installations (railways and pipelines), within which rail freight, with 22,369 million tonne-kilometres, represented 11.3% of total freight traffic; and -1.3% for air transport, which accounts for a very marginal share, primarily due to its focus on international freight movements (Table 2).
The rail share of total freight transport is below the EU average.. In 2023, it stood at 11.3% in Italy, compared to 17.6% at the European level. Moreover, Italy has the lowest railway network density relative to population among major European countries. Therefore, increasing rail usage—for both private and commercial purposes—and enhancing the integration among various transport modes may contribute to decarbonisation efforts and to improving the competitiveness of Southern Italy.
From 1990 to 2005, the modal split of freight transport remained relatively stable (Table 2). Specifically, between 2005 and 2016, road freight transport experienced a decrease of approximately 15 percentage points, followed by an upward trend through to 2023. In contrast, maritime transport saw a steady increase in its share starting in 2002, peaking around 2018, with a slight downward trend in the last three years. The share of rail freight has remained fairly constant over the historical series, averaging around 11%, with a slightly more pronounced decline observed between 2009 and 2011.
This evolution cannot be considered satisfactory, as it does not align with the development goals and intermodal shift strategies outlined in recent national planning instruments, which advocate for further modal shift interventions—from road to rail and from road to sea. The current modal distribution still requires greater balance between rail and maritime transport, along with a reduction in the share of road freight.
Data
Table 1: Total inland freight traffic in Italy, by mode of transport
Data from CNIT and ISPRA elaboration based on information from MIT, Confetra, Federtrasporto, Istat, EUROSTAT, and Centro Studi Subalpino.
Italicized values indicate estimated data - Sums may not match totals due to rounding.
(1) Only freight movements carried out by national carriers with both origin and destination within Italian territory are considered. For rail and pipeline transport, the domestic segment of international traffic is also included. The table is based on data series from various sources, derived from surveys conducted using different and non-comparable methodologies and systems.
(2) The transported goods, as required by the relevant EU Regulation, do not include the weight of empty private wagons.
(3) Movements of single locomotives are not included.
(4) From 2009 to 2012, the comparison of annual data between the two groups of companies (large and small-medium enterprises) must consider that the universe of these groups may vary each year, depending on the volume of freight traffic carried out by each company, according to the thresholds defined by EC Regulation No. 91/2003. Since 2013, the universes of the two groups have coincided. Starting from 2016, EU Regulation No. 2032/2016 (which amended EC Regulation No. 91/2003) introduced new traffic thresholds, resulting in a different classification of “large enterprises” and “small and medium enterprises” compared to previous years. EU Regulation No. 2032/2016 was later incorporated into EU Regulation No. 643/2018.
(5) For comparison purposes, the historical series of total road freight transport (domestic and international) is also reported, including the traffic of foreign carriers (EU 27 and EU 28).
Table 2: Percentage Share of Total Domestic Freight Traffic in Italy, by Mode of Transport
ISPRA elaboration based on data from the National Account of Infrastructure and Transport (CNIT) 2022–2023
Table 3: Transport intensity – Total and Freight-Specific – Relative to Income and Population
ISPRA elaboration using data from:
- MIT (Italian Ministry of Infrastructure and Transport)
- ISTAT (Italian National Institute of Statistics)
- EUROSTAT (Statistical Office of the European Union)
(1) Analysis restricted to vehicular transport with minimum payload capacity ≥3.5 metric tons. The freight transport operational definition encompasses: (i)trucks, (ii) vans, and (iii) foreign-registered vehicles (considering only the route segments traversing Italian territory). ISTAT has revised road freight transport data on several occasions; as a result, the historical series is not fully representative. The historical mileage series has been recalculated in accordance with updates to the ISPRA National Atmospheric Emissions Inventory.
Figure 1: Transport intensity (total and freight-specific) relative to income and population
Data source: ISPRA processing of data from MIT, ISTAT, and EUROSTAT
1) Analysis restricted to vehicular transport with minimum payload capacity ≥3.5 metric tons. The freight transport operational definition encompasses: (i) trucks, (ii) vans, and (iii) foreign-registered vehicles (considering only the route segments traversing Italian territory). ISTAT has revised road freight transport data on several occasions; as a result, the historical series is not fully representative. The historical mileage series has been recalculated in accordance with updates to the ISPRA National Atmospheric Emissions Inventory.
Figure 2: Total inland freight traffic in Italy, by mode of transport
CNIT data and ISPRA elaboration based on data from MIT, Confetra, Federtrasporto, ISTAT, EUROSTAT, and Centro Studi Subalpino
Italicized values indicate estimated data - Sums may not match totals due to rounding.
-
The data refer to freight movements carried out by national carriers with both origin and destination within Italian territory. For rail and pipeline transport, the domestic portion of international traffic is also included. The table is based on data series from different sources, derived from surveys conducted using non-comparable methodologies and systems.
-
As required by the relevant EU regulation, the transported goods do not include the weight of empty private wagons.
-
Movements of single locomotives are not included.
-
From 2009 to 2012, the comparison between annual data for the two company groups (large and small-medium enterprises) must take into account that the population of these two groups may vary each year based on the volume of freight traffic handled by individual companies, according to the thresholds set by EC Regulation No. 91/2003. As of 2013, the populations of the two company groups coincide. Starting in 2016, EU Regulation No. 2032/2016 (amending EC Regulation No. 91/2003) introduced new traffic thresholds, resulting in a numerical change in the classification of "large enterprises" and "small and medium enterprises" compared to previous years. EU Regulation No. 2032/2016 was subsequently consolidated into EU Regulation No. 643/2018.
-
For comparison purposes, the historical series of total road freight transport (domestic and international) is also reported, including the traffic of foreign carriers (EU-27 and EU-28).
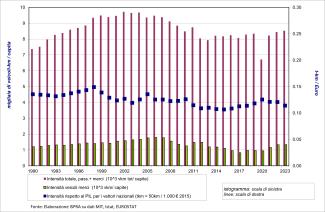
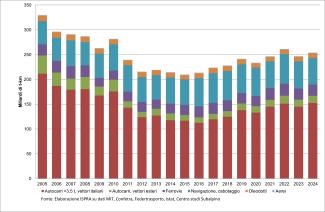
In Italy, between 1990 and 2016, road freight traffic for distances over 50 km carried out by Italian hauliers using vehicles over 3.5 tonnes declined by 25.7%. Starting in 2017, an upward trend has been observed, and for 2023, the National Transport Account (MIT) estimates a value comparable to pre-economic crisis levels in 2011, with a year-on-year increase of 0.8%.
From 1990 to 2023, rail freight transport grew by approximately 2.1%, despite a negative trend between 2017 and 2020. This was preceded by a period of growth from 2014 to 2016, with a historical low recorded in 2009. As of 2023, total rail freight traffic is estimated at approximately 22 billion tonne-kilometres, representing a decrease of 8.1% compared to 2022 (Table 1).
Maritime and inland waterway freight transport, whose modal share is estimated at around 21.2% of the total in 2023, increased by 18% in terms of traffic volume over the 1990–2023 period (Table 2), largely driven by the growth in container shipping. Air freight transport experienced an even more significant increase (+99.3% over the same period), recovering the volumes lost in 2020 due to the pandemic crisis. However, its modal share remains minimal in 2023, mainly because it serves predominantly international freight flows and remains aligned with the previous year.
Regarding freight transport intensity (all modes), measured as tonne-kilometres per unit of GDP for national hauliers (road > 50 km), the historical trend—despite the limitations in freight traffic estimates highlighted in the notes to Table 3—shows a notable decline between 2011 and 2015. Between 2016 and 2019, the indicator increased, reflecting the broader economic recovery. In 2022, the index shows a year-on-year decrease.
A marked decoupling is evident in 2011, when GDP grew modestly by 1% compared to the previous year, while freight intensity (measured in tkm/GDP) declined by 9% across all transport modes. Conversely, in 2020, GDP contracted by 9%, but freight intensity increased by 6%, likely due to the relative resilience of the freight sector during the pandemic, ensuring supply chains for production activities and end consumers despite the widespread shutdown of many economic sectors.
The evolution of road freight intensity, measured in vehicle-kilometres per unit of GDP (Table 3), mirrors the trend of total freight traffic, peaking around 2007.